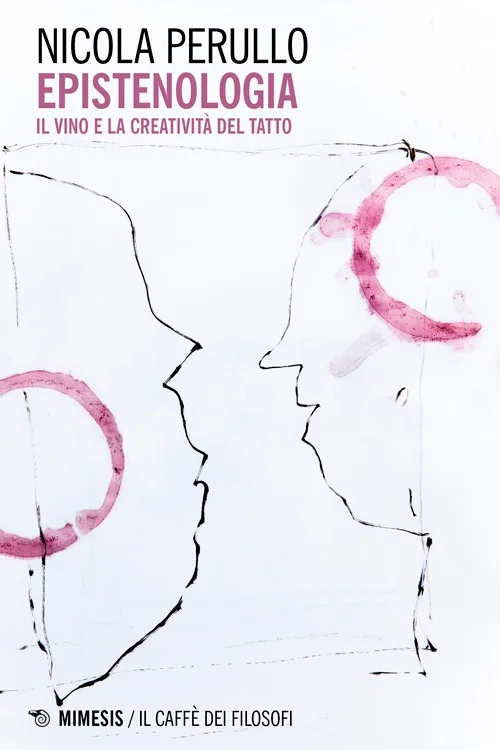Epistenologia - Confessioni di un bevitore seriale di mezza età
/Premessa: Epistenologia non è un libro per tutti. Non tanto per i suoi contenuti, a mio avviso, stimolanti e largamente condivisibili, bensì per il linguaggio scelto dall’autore. Nicola Perullo è professore di Estetica, quindi filosofo, e non fa nessuno sforzo per nasconderlo, scegliendo di proposito un linguaggio tecnico (filosofico, appunto) che non rende la lettura particolarmente scorrevole. Ciò nonostante, se siete il tipo di lettore che accetta le sfide e non si lascia facilmente spaventare, Epistenologia (Mimesis Edizioni, 2016, 107 pagine, 10 euro) è un libro capace di offrire numerosi spunti su cui riflettere tanto al neofita che si accosta per la prima volta al mondo del vino quanto al degustatore esperto.
L'autore
Nell’introduzione Perullo ripercorre le tappe della parabola esperienziale che molti appassionati di vino (me compresa) hanno attraversato quasi inevitabilmente: l’iniziale stupore per la magia creata dal vino, il desiderio di conoscenza, il forte entusiasmo per le scoperte, l’esibizione delle proprie competenze, l’assaggio seriale e compulsivo, il disagio di fronte alla misurazione, il distacco dalla degustazione classica e la presa di coscienza che l’incontro con un vino è unico e irripetibile come con gli esseri umani.
Partendo da questa premessa, l’autore ci guida attraverso le sue esperienze lungo un percorso obbligato e alquanto impervio, in cui esplora la relazione con il vino, spiega le ragioni che lo hanno condotto a rifiutare la degustazione in favore di quello che lui stesso definisce gusto aptico, propone una visione creativa dell’incontro con il vino e infine formula delle ipotesi sulle possibili modalità di comunicazione di un approccio tanto diverso.
Il primo capitolo, Incontrare il vino, si apre con un’ipotesi molto interessante: se accostarsi a un vino implica la costruzione di una relazione, l’oggettività ha ben poco a che fare con esso. “Una relazione – scrive Perullo – può essere breve o lunga; superficiale o profonda; complicata o leggera; non certo oggettiva” (p.25), né potrebbe esserlo, perché la relazione dipende contemporaneamente da chi beve, dall’artefice della bottiglia, da quella stessa bottiglia e dal contesto nel momento preciso dell’incontro. Da lì partono alcune considerazioni sul modo in cui la scienza ha cancellato l’esperienza della degustazione tattile, esperienziale e relazionale, trasformandola in una degustazione oggettiva, destrutturata (visiva, olfattiva e gustativa) e, in qualche modo, medicalizzata, riducendo “il corpo a una macchina” (p. 45).
Tra la degustazione rassicurante imposta dalla scienza (nella quale “il contesto, tutto il processo e il groviglio – del vino e di me che lo bevo e del tempo, scompaiono”, p. 48) e quello che Perullo chiama gusto aptico, c’è tutta la differenza che corre tra essere narcisisti e mettersi in discussione, tra restare “psichicamente immobili” e mescolare le proprie superfici porose con quelle del vino, tra annullare la propria immaginazione e darle libro sfogo. Ma darle libero sfogo, come sottolinea Perullo nel terzo capitolo, La creatività del tatto, significa affrontare l’ignoto, esplorare un territorio a noi sconosciuto – quello dell’incontro – e lasciarsi cambiare dall’esperienza in corso. Bere in modo creativo è proprio questo: “divertirsi, godere, scaldarsi, pensare, rimanere indifferenti, socializzare, parlarsi, muoversi insieme ad esso (…) E poi quello che resta dopo il passaggio, una eco, un’eredità che lascia giustizia dell’intreccio creato” (p.75).
Ovviamente l’autore non può fare a meno di chiedersi nell’ultimo capitolo, Le lingue del vino, tutte, in che modo dovremmo comunicare l’esperienza vissuta, l’esplorazione e il cambiamento attraverso l’incontro con il vino. Perullo è perfettamente consapevole del fatto che questo tipo di percezione aptica è metaforico tanto quanto un punteggio in centesimi o un elenco di aromi presenti in un vino, ma a differenza di questi ultimi non spersonalizza la relazione né impedisce il cambiamento, ovvero la costruzione personale di un proprio percorso. Non esistono sacerdoti, perché tutti siamo esperti di relazioni, sembra suggerire l’autore. E a chi ribatte che la vera democrazia del gusto risiede nella riproducibilità dell’esperienza, garantita da punteggi e descrittori universalmente riconosciuti, Perullo ricorda che le parole usate per descrivere un vino “sono la mappa del territorio”, non il territorio stesso, quindi sono in grado di guidare l’esploratore e chi lo ascolta attraverso l’ignoto: “ogni descrizione ha valore testimoniale, come fotografia di un viaggio compiuto oppure come souvenir di un viaggio mai fatto” (p. 87).
Chiunque dovrebbe coltivare il proprio linguaggio in modo personale, attraverso la costruzione e la condivisione con gli altri, e chiunque è in grado di farlo, a patto che lasci da parte la paura e si tuffi: “un assaggio procede a tentoni, creando una lingua necessariamente imperfetta”, ma è proprio questa imperfezione a sottrarre l’assaggio alla banalità che scaturisce dall’uso di quello che Perullo chiama “lessico pavloviano della degustazione” perché “le lingue del vino devono partire dai sogni” (p. 92), come aveva già felicemente intuito Mario Soldati.
Questi solo i nodi principali, ma Epistenologia è molto più di questo. È un libro che condensa in un centinaio di pagine molta sostanza, disseminato di pensieri, immagini poetiche e frasi efficaci che invitano il lettore alla sottolineatura, un libro ricco, insomma, ma non generosissimo. E questo è l’unico (piccolo) neo: a tratti si ha l’impressione che, anziché tuffarsi ancor più in profondità ed esplorare i fondali appena descritti, Perullo preferisca ritrarsi e risalire in superficie, in acque più sicure, magari ripetendo un concetto già espresso, soprattutto nell’ultimo capitolo, e mollandoci a metà di un ragionamento rischioso. Segno dei tempi o solo un vuoto lasciato di proposito in vista di una prossima pubblicazione?
Ai posteri l’ardua sentenza.